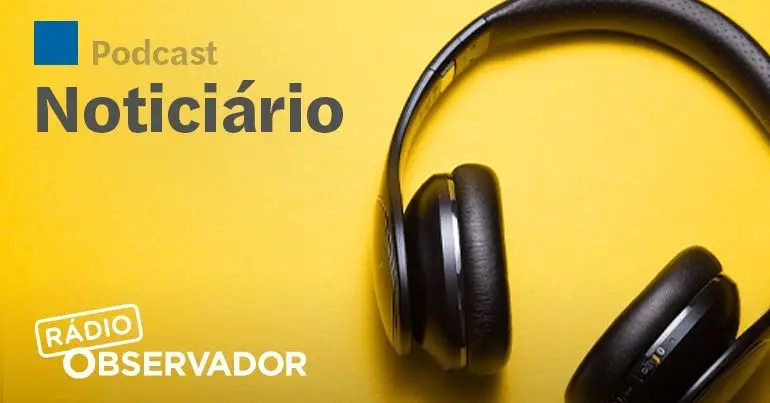Caratteristiche elementari del razionalismo cartesiano (parte I)

La filosofia cartesiana segna una svolta nella storia del pensiero occidentale. Contrariamente a un presupposto condiviso dalla maggior parte dei pensatori rinascimentali, Cartesio non partì da una credulità spontanea e acritica riguardo al funzionamento della natura, né mostrò la stessa venerazione per la filosofia classica dei suoi contemporanei. Motivato dalla Rivoluzione scientifica in corso e dalla necessità di confutare lo scetticismo radicale, il suo obiettivo principale era quello di creare un sistema filosofico in grado di ancorare i recenti progressi della fisica.
Cartesio cercò quindi di stabilire un metodo che gli permettesse di distinguere oggettivamente tra ciò che è falso e ciò che è vero. Va notato che alcune sfumature metodologiche derivanti dalla filosofia medievale persistevano ancora al momento del completamento della sua formazione accademica. Dopo aver studiato per sei anni presso il collegio gesuita di La Flèche, dove prevaleva un paradigma didattico prevalentemente scolastico, il filosofo francese avrebbe poi dimostrato la sua insoddisfazione per il modello delle disputationes. La sua convinzione era incrollabile che tutto ciò che è incerto sia incongruente con la scienza, in quanto privo di un metodo che consenta di percepire il verificarsi degli errori.
È importante ricordare che la Scolastica si sviluppò in stretta connessione con l'aristotelismo, ereditandone, tra molti altri aspetti, la fisica. La fisica aristotelica considerava una nozione qualitativa dell'essere, designando la "forma sostanziale" come il principio interno da cui scaturisce l'azione di un corpo, cioè il suo movimento. A sua volta, nel sistema cartesiano, il cosmo è interpretato come una sorta di estensione algoritmica, in modo che tutti i fenomeni possano essere spiegati matematicamente. Ciò significa che Cartesio rinuncia all'attributo qualitativo dell'essere, affermando che la natura è misurabile e che, in questo senso, il mondo fisico è essenzialmente quantitativo.
Da una prospettiva epistemologica, il filosofo francese prende le distanze dalla tradizione aristotelico-tomista – il cui cardine era l'indagine sull'esistenza dell'oggetto in questione – propugnando un nuovo spettro di analisi che riguarda non solo il rapporto tra il pensiero e i suoi correlati sensibili, ma soprattutto le caratteristiche dell'atto noetico stesso, che trascende ogni possibile corrispondenza con la corporeità del mondo. Il pensiero non può sempre identificare una realtà esterna che gli si addica, rendendo importante interrogarsi sulla sua connessione con il mondo.
Fu la matematica a rivelare a Cartesio la rilevanza di questa questione, poiché la conoscenza matematica convalida l'affermazione che esistono concetti che, pur privi di un correlato sensibile, contengono tuttavia una realtà propria, comprensibile dall'intelletto umano. Il razionalismo cartesiano contesta questa scienza non solo in quanto oggettivamente precisa nella sua applicazione al mondo, ma anche come possibilità di liberare la ragione dagli elementi qualitativi generati dall'apprezzamento dei dati empirici. Cartesio intendeva dimostrare, quindi, che l'intelletto è capace di conoscere da solo, cioè senza la necessità di ricorrere ad alcun contenuto sensoriale-percettivo. Il processo attraverso il quale gli esseri umani conoscono le cose, ovvero l'insieme delle funzioni cognitive che portano all'acquisizione della conoscenza, diventa quindi l'asse primordiale del pensiero filosofico; questo riorientamento epistemologico assumerà infine un'importanza cruciale nello sviluppo della cultura occidentale, motivo per cui al matematico francese viene attribuito il merito di aver fondato la filosofia moderna.
Il dubbio cartesiano non nasce dall'esperienza dell'errore sistematico, ma piuttosto dalla necessità di separare il vero dal falso; è un dubbio volontario, metodico e, in seguito, iperbolico. Epistemologicamente, è imperativo che tutto ciò che potrebbe dare origine ad ambiguità venga messo in discussione, a differenza di quanto accade nella realtà quotidiana, dove gli esseri umani orientano la loro pratica in base a ciò che è plausibile. Nella seconda parte del Discorso sul metodo , attingendo a una procedura logica utilizzata dai geometri, Cartesio presenta i quattro precetti che, a suo avviso, sono indispensabili per garantire la validità epistemica della conoscenza:
Il primo consisteva nel non accettare mai nulla come vero senza conoscerlo chiaramente come tale: (…) di includere nei nostri giudizi solo ciò che si presentava alla mia mente in modo così chiaro e distinto da non avere motivo di dubitarne. Il secondo consisteva nel dividere ciascuna delle difficoltà che dovevo esaminare nel maggior numero possibile e necessario di parti per risolverle al meglio. Il terzo consisteva nel condurre i miei pensieri in ordine, cominciando dagli oggetti più semplici e facili da comprendere, salendo gradualmente (…) alla conoscenza di quelli più complessi. E l'ultimo consisteva nel fare sempre enumerazioni così complete e rassegne così generali da essere certo di non omettere nulla.
Ci sembra ragionevole che il dubbio cartesiano manchi, nel Discorso sul metodo , della dimensione metafisica ravvisabile in altri testi. Infatti, nel preambolo della quarta parte di quest'opera, il filosofo francese evidenzia tre fattori che giustificano l'applicazione del dubbio metodico: 1) sappiamo che le informazioni derivate dai sensi sono fuorvianti, quindi nessuna credenza empirica dovrebbe essere considerata vera (questa argomentazione è corroborata dagli scettici e mette in discussione la validità della conoscenza a posteriori). 2) nell'ambito della logica e della matematica, gli esseri umani commettono paralogismi anche nei ragionamenti più semplici. 3) certi sogni sono indistinguibili dalle nostre percezioni da svegli e, in quanto tali, non vi è alcuna certezza che la vita stessa non sia un sogno.
Tuttavia, nelle Meditazioni sulla filosofia prima , con l'evocazione dell'argomento dell'ingannatore (un dio ingannatore), il dubbio raggiunge la sua fase iperbolica, con la sospensione del giudizio che si applica a tutta la realtà estrinseca al pensiero; questo momento si traduce, quindi, nella sospensione totale dell'ontologia del mondo. Tuttavia, anche considerando l'ipotesi di un dio che potrebbe ingannarlo costantemente su tutto, Cartesio intuisce con grande chiarezza e distinzione la sua esistenza come "cosa pensante". In definitiva, il dubbio si applica a tutto tranne che a se stesso; cioè, in termini epistemologici, è possibile dubitare di qualsiasi contenuto pensabile; tuttavia, non è possibile dubitare della realtà formale del dubbio stesso. Questo perché il dubbio rappresenta un'unità del pensiero, e il pensiero in azione è già una forma dell'essere la cui realtà non può essere messa in discussione: penso, dunque sono (cogito, ergo sum). Questo è, in effetti, il principio fondamentale che sostiene la validità della conoscenza e che di conseguenza ci permette di confutare lo scetticismo radicale.
observador