Una critica liberale al tentativo di sciogliere Chega.
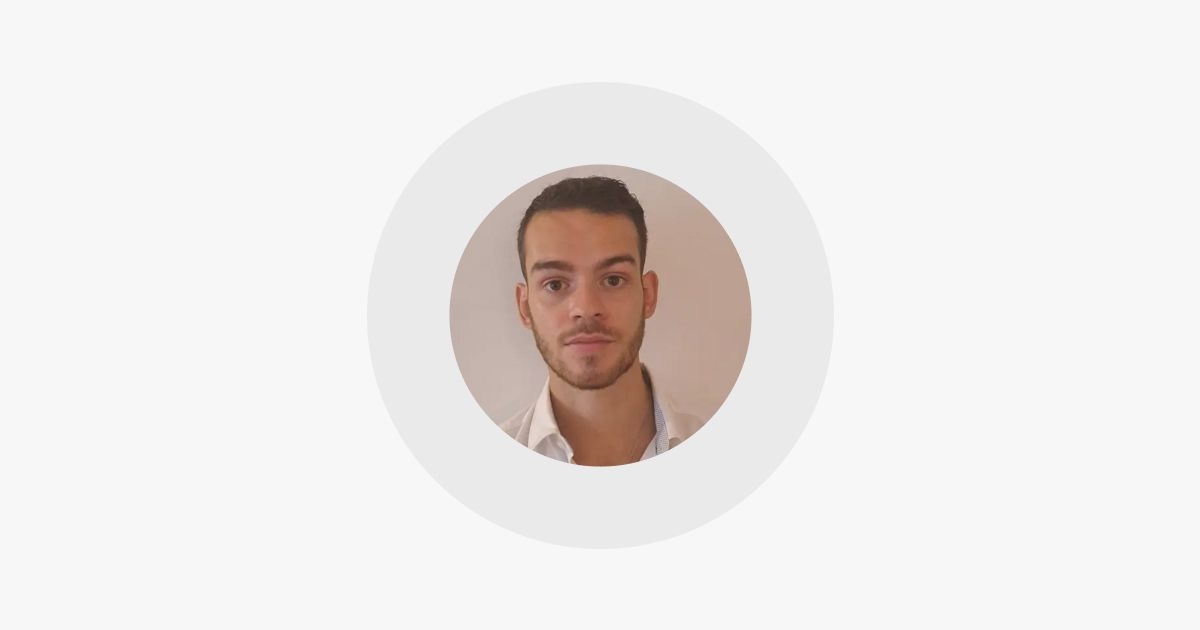
Nell'ottobre 2025, l'avvocato António Garcia Pereira ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica, chiedendo lo scioglimento del Chega ai sensi dell'articolo 46, comma 4, della Costituzione della Repubblica portoghese. A suo avviso, il partito violava i principi fondamentali dell'ordine costituzionale promuovendo discorsi d'odio e ideologie contrarie alla dignità umana.
Questo caso è più simbolico che giuridico: ci costringe a ripensare i limiti della libertà politica e la coerenza interna di un sistema che si proclama democratico e pluralista, ma che allo stesso tempo proibisce certe forme di organizzazione ideologica. Se la libertà politica è, come si dice, uno dei pilastri della democrazia, fino a che punto lo Stato può decidere quali ideali siano ammissibili?
La Costituzione sancisce ampi diritti e libertà fondamentali, sebbene molti di essi siano soggetti a limiti espressamente stabiliti dalla Costituzione stessa o a interpretazioni restrittive da parte della Corte Costituzionale. Nel caso in esame, si tratta di un limite di seconda categoria.
Nello specifico, la libertà di associazione, riconosciuta dall'articolo 46, è limitata dal paragrafo 4, che recita: "Non sono ammesse le associazioni armate, né quelle di tipo militare, militarizzato o paramilitare, né le organizzazioni razziste o che sposano l'ideologia fascista". La norma ha una chiara radice storica: il trauma del regime dell'Estado Novo (Stato Nuovo) e il timore di un possibile ritorno all'autoritarismo.
Tuttavia, questa eccezione rivela un paradosso: per proteggere la libertà, la Costituzione accetta di limitare la libertà stessa. La democrazia diventa così un regime che difende preventivamente non solo dagli atti violenti, ma anche dalle idee. Questo è ciò che Karl Popper chiamava il "paradosso della tolleranza": la necessità di non tollerare gli intolleranti per preservare una società aperta.
Ma fino a che punto è legittimo che lo Stato assuma questo ruolo paternalistico, decidendo cosa i cittadini possono o non possono difendere politicamente?
Da una prospettiva politologica, Chega non può essere classificato a rigore come un partito fascista. Il fascismo storico – in quanto movimento totalitario rivoluzionario – presupponeva l'abolizione del pluralismo, la "corporativizzazione" dello Stato, il culto della violenza e la negazione della "democrazia rappresentativa".
Chega, a sua volta, è un partito politico nazionalista di destra, che opera all'interno del sistema parlamentare, entro i limiti dello stato di diritto, e la cui ideologia è più moralista e orientata alla sicurezza che autenticamente totalitaria. Le sue posizioni sull'immigrazione, sulle minoranze o sulla criminalità possono essere controverse e persino demagogiche, ma non rappresentano un progetto per distruggere la democrazia.
Proibirne l'esistenza sarebbe quindi un errore concettuale e politico: confonderebbe la critica radicale del sistema con il tentativo di rovesciarlo, cosa che, nella tradizione liberale, deve essere combattuta con argomentazioni, non con divieti.
Il liberalismo classico si basa sull'idea che la libertà di espressione debba essere limitata quando causa un danno concreto agli altri. Punire solo idee o parole è incompatibile con uno Stato veramente libero.
L'attuale espansione dei "crimini d'odio" riflette una deriva moralistica del diritto penale: un "diritto penale dei sentimenti" che trasforma i reati simbolici in reati pubblici. Uno Stato liberale non esiste per proteggere i cittadini dal sentirsi offesi, ma per proteggere le loro vite e proprietà da danni reali.
Pertanto, anche se una parte adotta una retorica provocatoria, il limite legittimo della punizione dovrebbe essere l'azione, non l'intenzione. Punire le parole è il primo passo per punire i pensieri.
È interessante notare che, sebbene la Costituzione proibisca le organizzazioni fasciste, non proibisce quelle comuniste, nonostante l'esperienza storica dimostri che entrambi i movimenti hanno dato origine a regimi totalitari. Il Partito Comunista Portoghese, che si dichiara erede di un'ideologia responsabile di milioni di morti e della soppressione di diritti e libertà, è una forza pienamente legittima nel sistema politico portoghese.
La "democrazia liberale" contemporanea si presenta come un regime di libertà, pluralità e neutralità ideologica. Tuttavia, quando ne osserviamo le pratiche, ci rendiamo conto che questa neutralità è spesso solo apparente.
Come osservò Carl Schmitt, ogni ordine politico si fonda su una distinzione essenziale tra amico e nemico. La democrazia, nel suo apparente tentativo di essere universale e inclusiva, finisce per creare i propri nemici interni: coloro che "non condividono i suoi valori". Paradossalmente, la "democrazia liberale" difende la libertà escludendo coloro che la interpretano diversamente.
Lo stesso Stato che proclama la libertà di pensiero è quello che definisce quali pensieri sono accettabili. Il fascismo istituzionalizzato si trasforma così in una sorta di dogma ufficiale: una religione moderna in cui alcune convinzioni politiche sono sacre e altre eretiche.
Questa tendenza non è esclusiva del Portogallo. In tutta Europa, l'antifascismo giuridico e culturale è diventato uno strumento di conformismo morale, utilizzato per definire i confini di ciò che è accettabile e mettere a tacere il dissenso. Il risultato è una democrazia sempre più moralizzata, meno razionale e più intollerante in nome della tolleranza.
Come ho già detto, Karl Popper sosteneva che una società tollerante non può tollerare persone intolleranti, pena l'autodistruzione. Questa tesi viene spesso invocata per giustificare la proibizione dei movimenti estremisti.
Ma c'è un problema: chi definisce chi è "intollerante"? Se il potere politico si attiene a questo criterio, si apre la strada all'assolutismo morale, in cui qualsiasi opposizione radicale può essere etichettata come "antidemocratica".
Hannah Arendt, studiando i regimi totalitari, ha dimostrato che il pericolo non risiede solo nell'ideologia, ma anche nella fusione tra morale e politica, quando lo Stato inizia a punire il pensiero deviante in nome del bene comune. In questo senso, il costituzionalismo antifascista europeo, nel tentativo di prevenire il male, rischia di riprodurne i meccanismi: censura, sorveglianza e punizione delle idee.
Se crediamo veramente nella libertà politica, allora dobbiamo accettare il diritto di qualcuno di essere antidemocratico, purché non ricorrano alla violenza.
La libertà che esclude l'errore è una libertà simulata. La democrazia che non tollera la sua negazione è, in fondo, una tirannia delle buone maniere.
In uno stato veramente liberale, la lotta contro le idee estreme si combatte attraverso il dibattito, non con scioglimenti giudiziari. È la discussione, non il tribunale, che dovrebbe sconfiggere l'avversario politico.
Sciogliere Chega (o qualsiasi altro partito) sulla base di criteri morali sarebbe una vittoria di Pirro per la democrazia: la democrazia vincerebbe, ma la sua anima andrebbe perduta.
La richiesta di scioglimento di Chega rappresenta più di un semplice episodio giuridico: riflette un profondo dilemma della democrazia moderna.
La Costituzione portoghese, proibendo le ideologie fasciste e consentendo quelle comuniste, dimostra che la neutralità dello Stato è una finzione utile. E punendo l'incitamento all'odio senza arrecare danno effettivo, rischia di trasformare la libertà in un privilegio condizionato.
La democrazia liberale portoghese, nata dalla paura del passato, vive ancora all'ombra di quel trauma, proteggendosi a tal punto da dimenticare di respirare.
Forse la vera prova della maturità democratica è permettere anche ai suoi critici di esistere. Perché, come ci ha ricordato Mill, "la verità nasce dallo scontro di opinioni, non dal silenzio di alcuni in nome di altri".
observador




